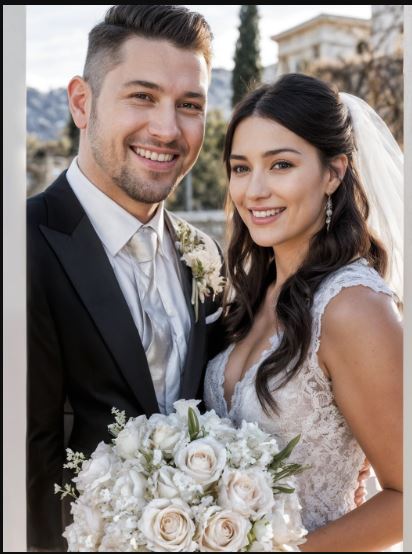Sono rientrata dal lavoro con un anticipo insolito, esausta, con addosso ancora la stanchezza dell’ufficio e quell’odore di neon e carta che ti resta addosso anche quando vorresti solo sparire sotto la doccia. Appena ho girato la chiave nella serratura, però, ho sentito subito che qualcosa era fuori posto.
Grisha era già lì, sulla soglia, come se mi stesse aspettando. E sul viso aveva un sorriso strano: troppo largo, troppo perfetto, quasi provato davanti allo specchio.
«Amore… giornata dura?» mi chiese, sfiorandomi la guancia con un bacio che aveva una dolcezza dimenticata.
«Un incubo,» sospirai, lasciando cadere la borsa sul tavolino. «Volevo solo togliermi le scarpe e smettere di esistere per cinque minuti.»
Lui batté le mani come un animatore in vacanza. «Allora vieni. Siediti. Ti faccio un massaggio ai piedi.»
Mi fermai di colpo.
Grisha. Un massaggio ai piedi.
Lo stesso uomo che sbuffava persino quando gli chiedevo di passarmi il telecomando. Per un istante ho provato a convincermi che fosse un gesto d’amore tardivo, un piccolo miracolo domestico. Ma la pancia mi si è chiusa nel modo preciso che avevo imparato a temere: quella stretta che arriva quando la realtà sta per tirarti uno schiaffo.
«Stai scherzando?» domandai, con un sopracciglio alzato.
«Serissimo.» Mi accompagnò verso il divano con un’attenzione quasi cerimoniale. «Te lo meriti.»
La stanchezza ebbe la meglio sulla diffidenza. Mi lasciai sfilare le scarpe e appoggiai i piedi. Le sue mani erano sorprendentemente gentili, ma il resto di lui era un fascio di nervi: spalle rigide, respiro corto. E ogni pochi secondi lanciava un’occhiata veloce verso il corridoio, come se stesse controllando un orologio invisibile.
Parlava troppo. Rideva troppo forte. Infilava nel silenzio frasi inutili, come se il silenzio lo potesse tradire.
«È… piacevole,» ammisi, ma più lo dicevo e meno mi suonava vero.
Lui fece una risatina. «Non posso coccolare mia moglie senza essere messo sotto interrogatorio?»
Stavo per rispondere, quando un rumore secco tagliò l’aria: un piccolo scatto, breve, come una maniglia mossa con troppa cautela. Veniva dal bagno.
Mi irrigidii. «Hai sentito?»
Grisha si immobilizzò per una frazione di secondo—quanto bastava. Poi ripartì con una risata nervosa. «I tubi. Lo sai… questa casa è vecchia.»
Vecchia o no, quello non era un tubo. Era un suono vivo. Umano.
«Grisha,» dissi piano, «che cosa sta succedendo?»
«Niente!» La sua voce salì di un tono, troppo acuta. «Sei stanca, ecco tutto. Rilassati…» Le dita ripresero a muoversi più in fretta, come se volesse incollarmi al divano.
Mi alzai lo stesso.
«Aspetta!» scattò lui, venendomi dietro. «Dove vai?»
Non risposi. Il corridoio, quella volta, sembrava allungarsi a ogni passo. Sentivo il cuore battere nei timpani e una parte di me pregava, pregava davvero, di essersi sbagliata. Ma quella parte lucida, quella che non si racconta favole, mi spingeva avanti.
Aprii la porta del bagno.
Mi investì un’aria calda e umida, come se qualcuno fosse appena passato di lì. Lo specchio era appannato, il termosifone rovente. Sul ripiano, tra i miei flaconi in fila, c’era un dettaglio che mi colpì come un pugno: un rossetto cremisi. Nuovo. Non mio.
Lo presi tra le dita e mi voltai.
Grisha era sulla soglia, bianco come un lenzuolo, con lo sguardo di chi cerca un’uscita dove non c’è.
«E questo?» chiesi, mostrando il tubetto.
Aprì la bocca, ma non uscì niente. Solo un fiato spezzato.
E allora feci l’unica cosa possibile. Aprii l’anta dell’armadio a muro, quello dove tenevamo asciugamani e scatole.
Dentro, rannicchiata come un animale braccato, c’era una donna. Stringeva tra le braccia un paio di décolleté dal tacco alto, i capelli scompigliati, le guance arrossate. E addosso aveva un accappatoio di seta.
Il mio.
Per un secondo il mondo perse suono. Rimase solo un ronzio, un vuoto denso. Poi la rabbia arrivò limpida, precisa, come una luce accesa all’improvviso.
«Chi sei?» domandai. La mia voce non sembrava la mia: ferma, fredda.
Lei si alzò lentamente, cercando di tirarsi addosso l’accappatoio come se quel gesto potesse salvarla. «Non… non è come pensi,» mormorò, già sapendo quanto fosse ridicola quella frase.
Grisha entrò nel bagno con le mani alzate, come se stesse disinnescando un ordigno. «Amore, ti prego. Fammi parlare.»
Mi voltai verso di lui, e la calma mi diventò tagliente. «Parlare di cosa? Che c’è una sconosciuta nascosta nel nostro armadio con le mie cose addosso? Che mi fai un massaggio ai piedi mentre lei aspetta lì dentro?»
La donna lo fissò, gli occhi larghi di panico. «Mi avevi detto che lei non sarebbe tornata…»
E quella frase fu peggio di tutto.
Perché non era un errore. Era un piano.
Alzai il rossetto come una prova in un’aula di tribunale. «Complimenti, Grisha. Ti sei organizzato alla perfezione.»
Lui fece un passo verso di me. «È stato solo… un momento. Una debolezza.»
«No.» Scossi la testa. «La debolezza è il massaggio. Il resto è una scelta.»
Indicai la porta, senza urlare. Non ce n’era bisogno. «Prendete le vostre cose. E uscite. Adesso.»
«Dai… per favore—» provò lui.
«Non chiamarmi “per favore”.» La voce mi tremò appena, ma non concessi lacrime. «Non hai più il diritto di chiedermi niente.»
La donna afferrò le scarpe e scivolò fuori dal bagno come un’ombra, sparendo nel corridoio. Grisha restò immobile un secondo, come se stesse valutando l’ultima manipolazione, l’ultima scena. Poi incontrò il mio sguardo e capì: non c’era più spazio.
Uscì anche lui.
E io rimasi lì, in piedi, con il rossetto in mano e lo specchio appannato davanti. Con una verità semplice e feroce: non era solo un tradimento. Era una vita intera in cui mi ero abituata a chiedere poco, a giustificare troppo, ad accontentarmi di mezze attenzioni e silenzi lunghi.
Quella sera non mi sono spezzata. Mi sono spostata.
Ho preso una scatola dal ripostiglio e ho iniziato a raccogliere le sue cose con una lucidità che mi ha spaventata: camicie, prodotti da barba, caricabatterie, la sua tazza preferita. Ogni oggetto era un ricordo. E io non volevo più fare da custode ai ricordi di chi mi aveva mentito.
Quando la scatola fu piena, chiamai mio fratello.
«Puoi venire?» dissi.
«Arrivo. Che succede?»
Deglutii. «Grisha non vive più qui.»
Non fece domande. Arrivò in mezz’ora, mi abbracciò forte e mi aiutò a portare tutto vicino alla porta. Il suo silenzio era un appoggio vero: niente prediche, niente “te l’avevo detto”. Solo presenza.
Quando Grisha tornò la sera dopo, era pronto a recitare di nuovo. Occhi lucidi, voce bassa, la faccia di chi spera in un perdono svenduto.
«Possiamo parlare?» chiese.
Indicai il mucchio delle sue cose. «No. Puoi solo prenderle.»
«Ti prego, ascoltami—»
«Ho ascoltato abbastanza per anni,» risposi, senza alzare la voce. «Adesso tocca a me.»
Restò fermo, come se aspettasse che mi sciogliessi. Poi capì che non sarebbe successo. Raccolse le sue cose e se ne andò. Finalmente senza teatro.
Il giorno dopo avviai le pratiche di divorzio. È strano firmare un foglio che taglia un filo lungo anni, come se stessi chiudendo una porta su una stanza in cui avevo respirato troppo poco. Ma sotto quello strano c’era una sensazione nuova: leggerezza.
Nei mesi successivi mi sono ripresa spazio, un pezzo alla volta. Ho cambiato la disposizione dei mobili, ho buttato via ciò che mi stringeva lo stomaco, ho riempito le stanze di voci e di cose che mi facevano bene. Ci sono state notti vuote, giornate in cui la rabbia tornava all’improvviso, momenti in cui inciampavo nei ricordi come in spigoli nascosti.
Ma ogni volta mi rialzavo più in fretta.
Una sera, seduta sul divano del mio soggiorno, ho guardato intorno a me e l’ho capito: ero tornata a casa. Non solo nella mia casa—nella mia vita.
Il tradimento di Grisha mi aveva ferita, sì. Ma mi aveva anche svegliata. Avevo difeso troppo a lungo un matrimonio che mi voleva piccola, paziente, comprensiva… mentre lui si concedeva il lusso di non esserlo mai.
Ora basta.
Ho chiuso quella porta senza nostalgia. E, per la prima volta dopo anni, ho guardato avanti non con paura, ma con rispetto. Per me stessa.